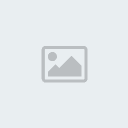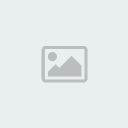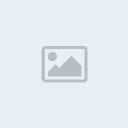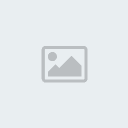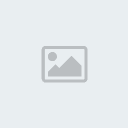Discorso per la pace di Obama ,dicembre 2009
Pagina 1 di 1
 Discorso per la pace di Obama ,dicembre 2009
Discorso per la pace di Obama ,dicembre 2009
Il discorso di Obama a Oslo
"Una pace giusta e duratura"
Le parole del presidente degli Stati Uniti in occasione dell'accettazione del premio Nobel per la pace: "A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio i miei successi sono poca cosa"
Vostra maestà, vostra altezza reale, illustri membri del Comitato norvegese per il premio Nobel, cittadini americani e cittadini del mondo intero:
ricevo questo onorificenza con profonda gratitudine e grande umiltà. È un premio che parla alle nostre aspirazioni più alte, che ci dice che, pur con tutta la crudeltà e le difficoltà del nostro mondo, non siamo unicamente prigionieri del fato. Quello che facciamo conta, e possiamo piegare la storia nel senso della giustizia.
Ma sarei negligente se sorvolassi sulle forti polemiche che ha suscitato vostra generosa decisione. In parte queste polemiche nascono dal fatto che io sono all'inizio, e non al termine, delle mie fatiche. A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio - Schweitzer e King, Marshall e Mandela - i miei successi sono poca cosa. E poi ci sono gli uomini e le donne in tutto il mondo che vengono incarcerati e picchiati perché cercano giustizia, ci sono quelli che lavorano duramente nelle organizzazioni umanitarie per alleviare le sofferenze, ci sono quei milioni senza nome che con i loro atti silenziosi di coraggio e di compassione sono di ispirazione anche per il più cinico degli individui. Non posso contestare le ragioni di chi sostiene che questi uomini e queste donne - alcuni noti, altri sconosciuti a chiunque tranne che a quelli che ricevono il loro aiuto - meritano questo riconoscimento molto più di quanto non lo meriti io.
Ma forse il problema maggiore è che io sono il comandante in capo di una nazione impegnata in due guerre. Una di queste guerre sta lentamente esaurendosi. L'altra è un conflitto che l'America non ha cercato, un conflitto a cui prendono parte insieme a noi altri quarantatré Paesi, compresa la Norvegia, nel tentativo di difendere noi stessi e tutte le nazioni da ulteriori attacchi.
Ciò non toglie però che siamo in guerra e che io sono responsabile del dispiegamento sul fronte, in una terra lontana, di migliaia di giovani americani. Alcuni di loro uccideranno. Alcuni saranno uccisi. Per questo vengo qui con l'acuta consapevolezza di quale sia il costo di un conflitto armato, carico di difficili interrogativi sul rapporto fra guerra e pace e sui nostri sforzi per sostituire la prima con la seconda.
Non sono interrogativi nuovi. La guerra, in una forma o nell'altra, ha accompagnato l'uomo fin dalle origini. Agli albori della storia nessuno ne metteva in discussione la moralità: la guerra era semplicemente un fatto, come la siccità o la malattia; era il modo con cui le tribù e poi le civiltà cercavano di acquisire potere e risolvevano le loro divergenze.
Col tempo, mentre i codici giuridici cercavano di mettere sotto controllo la violenza all'interno dei gruppi, filosofi, uomini di chiesa e statisti cercavano di regolamentare la forza distruttiva della guerra. Emerse il concetto di "guerra giusta", che sottintendeva che la guerra è giustificata solo quando rispetta determinate condizioni: e cioè se viene mossa come ultima ratio o per autodifesa, se la forza usata è proporzionata e se, nei limiti del possibile, i civili vengono risparmiati dalle violenze.
Raramente nella storia si è vista una guerra che rispondesse al concetto di guerra giusta. La capacità degli esseri umani di inventare nuovi modi per ammazzarsi a vicenda si è rivelata inesauribile, al pari della nostra capacità di escludere dalla compassione chi ha un aspetto diverso o prega un Dio diverso. Le guerre fra eserciti hanno lasciato il posto alle guerre fra nazioni, guerre totali dove la distinzione fra combattenti e civili diventava meno netta. Nell'arco di trent'anni, per due volte questo continente è precipitato nel gorgo della carneficina. E benché sia difficile immaginare una causa più giusta della sconfitta del Terzo Reich e delle potenze dell'Asse, la seconda guerra mondiale fu un conflitto dove il numero complessivo delle vittime fra i civili superò quello dei soldati caduti.
Sulla scia di una distruzione tanto vasta, e con l'avvento dell'era nucleare, divenne chiaro sia ai vincitori che ai vinti che il mondo aveva bisogno di istituzioni che prevenissero un'altra guerra mondiale. E così, venticinque anni dopo la bocciatura da parte del Senato americano della Lega delle Nazioni (un'idea per la quale Woodrow Wilson vinse questo premio), l'America guidò il mondo alla costruzione di un'architettura per mantenere la pace: il piano Marshall e le Nazioni Unite, strumenti per regolare la guerra, trattati per difendere i diritti dell'uomo, impedire genocidi e limitare le armi più pericolose.
Sotto molti punti di vista, questi sforzi ebbero successo. Sì, sono state combattute guerre terribili e sono state commesse atrocità. Ma non c'è stata nessuna terza guerra mondiale. La guerra fredda si è conclusa con folle entusiaste che distruggevano un muro. I commerci hanno legato insieme gran parte del pianeta. Miliardi di individui sono usciti dalla povertà. Gli ideali di libertà, autodeterminazione, uguaglianza e Stato di diritto si sono fatti timidamente strada. Noi siamo gli eredi della forza d'animo e della lungimiranza delle generazioni passate, ed è un'eredità di cui il mio Paese va giustamente fiero.
Ora che è passato un decennio dall'inizio del nuovo secolo, questa vecchia architettura comincia a cedere sotto il peso di nuove minacce. Il mondo forse non trema più al pensiero di una guerra fra due superpotenze nucleari, ma la proliferazione delle armi nucleari rischia di rendere più probabile una catastrofe. Il terrorismo è un'arma tattica usata da molto tempo, ma la tecnologia moderna consente a pochi, piccoli uomini con una rabbia smisurata di assassinare un numero terrificante di innocenti.
Inoltre, le guerre fra nazioni sono sostituite sempre più dalle guerre all'interno delle nazioni. La resurrezione di conflitti etnici o settari, la crescita di movimenti secessionistici, guerriglie e Stati allo sbando intrappolano sempre di più i civili in un caos senza fine. Nelle guerre odierne vengono uccisi molti più civili che soldati: si gettano i semi di conflitti futuri, si devasta l'economia, si lacera la società civile, si accumulano i profughi e si lasciano segni indelebili sui bambini.
Non ho qui con me, oggi, una soluzione definitiva ai problemi della guerra. Quello che so è che per affrontare queste sfide servirà la stessa capacità di visione, lo stesso duro lavoro, la stessa perseveranza di quegli uomini e di quelle donne che alcuni decenni fa hanno agito con tanto coraggio. E servirà un ripensamento dei concetti della guerra giusta e degli imperativi di una pace giusta.
Dobbiamo partire della consapevolezza di una verità difficile da mandare giù: non riusciremo a sradicare il conflitto violento nel corso della nostra vita. Ci saranno occasioni in cui le nazioni, agendo individualmente o collettivamente, troveranno non solo necessario, ma moralmente giustificato l'uso della forza.
Dico questa cosa pensando a quello che disse anni fa, in questa stessa cerimonia, Martin Luther King: "La violenza non porta mai una pace permanente. Non risolve nessun problema della società, anzi ne crea di nuovi e più complicati". Io, che sono qui come conseguenza diretta dell'opera di una vita del reverendo King, sono la testimonianza vivente della forza morale della nonviolenza. Io so che non c'è nulla di debole, nulla di passivo, nulla di ingenuo, nelle idee e nella vita di Gandhi e di Martin Luther King.
Ma in quanto capo di Stato che ha giurato di proteggere e difendere la mia nazione non posso lasciarmi guidare solo dai loro esempi. Devo affrontare il mondo così com'è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano. Perché una cosa dev'essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda a deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un'invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le imperfezioni dell'uomo e i limiti della ragione.
Sollevo questo punto perché in molti Paesi oggi c'è una profonda ambivalenza sulle azioni militari, qualunque sia la causa che le muove. In certi casi, a questa ambivalenza si aggiunge una diffidenza istintiva nei confronti dell'America, l'unica superpotenza militare del pianeta.
Ma il mondo deve ricordarsi che non sono state solo le istituzioni internazionali, non sono stati solo i trattati e le dichiarazioni a portare stabilità al pianeta dopo la fine della seconda guerra mondiale. A prescindere dagli errori che abbiamo commesso, il dato di fatto puro e semplice è questo: gli Stati Uniti d'America hanno contribuito per più di sessant'anni a proteggere la sicurezza globale, con il sangue dei nostri cittadini e la forza delle nostre armi. Lo spirito di servizio e di sacrificio dei nostri uomini e donne in uniforme ha promosso la pace e la prosperità, dalla Germania alla Corea, e ha consentito alla democrazia di insediarsi in luoghi come i Balcani. Abbiamo sopportato questo fardello non perché cerchiamo di imporre la nostra volontà. Lo abbiamo fatto per interesse illuminato, perché cerchiamo un futuro migliore per i nostri figli e nipoti, e siamo convinti che la loro vita sarà migliore se altri figli e nipoti potranno vivere in libertà e prosperità.
Dunque sì, gli strumenti della guerra contribuiscono a preservare la pace. Ma questa verità deve coesistere con un'altra, e cioè che la guerra, per quanto giustificata possa essere, porterà sicuramente con sé tragedie umane. C'è gloria nel coraggio e nel sacrificio di un soldato, c'è l'espressione di una devozione per il proprio Paese, per la causa e per i commilitoni. Ma la guerra in sé non è mai gloriosa e non dobbiamo mai sbandierarla come tale.
La nostra sfida dunque consiste in parte nel riconciliare queste due verità apparentemente inconciliabili. La guerra a volte è necessaria e la guerra è, a un certo livello, espressione di sentimenti umani. Concretamente, dobbiamo indirizzare i nostri sforzi al compito che il presidente Kennedy invocava molto tempo fa. "Concentriamoci", diceva lui, "su una pace più pratica, più raggiungibile, basata non su un improvviso capovolgimento della natura umana, ma su una graduale evoluzione delle istituzioni umane".
Come dovrebbe essere questa evoluzione? Quali potrebbero essere queste misure pratiche?
Per cominciare, io sono convinto che tutte le nazioni, sia le nazioni forti che le nazioni deboli, devono aderire a dei parametri per regolare l'uso della forza. Io, come ogni capo di Stato, mi riservo il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per difendere la mia nazione. Resto tuttavia convinto che aderire a delle regole sia qualcosa che dà maggior forza a chi lo fa e che isola - e indebolisce - chi non lo fa.
Il mondo si è stretto intorno all'America dopo gli attacchi dell'11 settembre e continua a sostenere i nostri sforzi in Afghanistan in virtù dell'orrore suscitato da quegli attacchi insensati e del principio riconosciuto dell'autodifesa. Allo stesso modo, il mondo ha riconosciuto la necessità di affrontare Saddam Hussein quando questi invase il Kuwait, un consenso che inviò un messaggio chiaro a tutti sul prezzo che devi pagare se vuoi compiere un'aggressione.
L'America non può pretendere che gli altri rispettino le regole della strada se lei si rifiuta di rispettarle. Perché quando non lo facciamo le nostre azioni appaiono arbitrarie e minano la legittimità di interventi futuri, non importa se giustificati o meno.
Questo diventa particolarmente importante quando lo scopo dell'azione militare va al di là dell'autodifesa o della difesa di una nazione da un aggressore. Tutti siamo alle prese sempre di più con difficili interrogativi su come impedire massacri di civili da parte del loro stesso governo, o su come fermare una guerra civile che rischia di risucchiare nelle violenze e nelle sofferenze un'intera regione.
Io sono convinto che l'uso della forza possa essere giustificato per ragioni umanitarie, come è stato nei Balcani o in altri posti segnati dalla guerra. Restare a guardare lacera la nostra coscienza e può condurre a interventi più costosi in un secondo momento. Ecco perché tutte le nazioni responsabili devono accettare il ruolo che possono giocare le forze armate, con un mandato chiaro, per il mantenimento della pace.
L'impegno dell'America nei confronti della sicurezza del mondo non verrà mai meno. Ma in un mondo dove le minacce sono più diffuse, e le missioni più complesse, l'America non può agire da sola. Questo vale per l'Afghanistan. Questo vale per Stati allo sbando come la Somalia, dove il terrorismo e la pirateria si accompagnano a fame e sofferenze. E purtroppo continuerà a valere ancora per anni a venire nelle regioni instabili.
I dirigenti e i soldati dei Paesi della Nato, e di altri Paesi amici e alleati, dimostrano questa verità attraverso la capacità e il coraggio di cui hanno dato prova in Afghanistan. Ma in molti Paesi c'è uno scollamento fra gli sforzi delle truppe e l'ambivalenza della cittadinanza. Io capisco i motivi dell'impopolarità della guerra. Ma so anche questo: pensare che la pace sia auspicabile di solito non basta per ottenere la pace. La pace richiede responsabilità. La pace comporta sacrificio. Ecco perché la Nato resta indispensabile. Ecco perché dobbiamo rafforzare le operazioni di peacekeeping dell'Onu e regionali, e non lasciare che siano pochi Paesi a farsene carico. Ecco perché rendiamo omaggio a chi ritorna a casa da operazioni di peacekeeping e addestramento, a Oslo e a Roma, a Ottawa e a Sydney, a Dacca e a Kigali: rendiamo omaggio a queste persone non come costruttori di guerra, ma come edificatori di pace.
Voglio dire un'ultima cosa sull'uso della forza. Anche quando prendiamo la difficile decisione di cominciare una guerra, dobbiamo pensare chiaramente a come questa guerra va combattuta. Il Comitato per il Nobel lo riconobbe assegnando il primo Nobel per la pace a Henry Dunant, il fondatore della Croce rossa e uno dei principali promotori delle Convenzioni di Ginevra.
Laddove è necessario usare la forza, abbiamo un interesse morale e strategico ad attenerci a determinate regole di comportamento. E anche quando affrontiamo un avversario crudele, che non rispetta nessuna regola, sono convinto che gli Stati Uniti debbano continuare a farsene portatori. È questo che ci rende diversi da coloro che combattiamo. È anche da qui che ricaviamo la nostra forza. È per questo che ho vietato la tortura. È per questo che ho ordinato la chiusura della prigione di Guantánamo. Ed è per questo che ho riaffermato l'impegno dell'America al rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Perdiamo noi stessi quando scendiamo a compromessi proprio su quegli ideali che lottiamo per difendere. E onoriamo quegli ideali se li rispettiamo non soltanto quando è facile farlo, ma anche quando è difficile.
Ho parlato degli interrogativi che dobbiamo tenere presenti nel cuore e nella mente quando scegliamo di muovere guerra. Ma ora voglio soffermarmi sugli sforzi che possiamo fare per evitare scelte tanto tragiche, e voglio parlare di tre vie per costruire una pace giusta e duratura.
La prima riguarda l'approccio da adottare nei confronti di quelle nazioni che violano le regole e le leggi: sono convinto che dobbiamo sviluppare alternative alla violenza che siano sufficientemente efficaci da modificare i comportamenti, perché se vogliamo una pace duratura allora le parole della comunità internazionale devono avere un significato. Quei regimi che violano le regole devono essere chiamati a risponderne. Le sanzioni devono essere realmente incisive. All'intransigenza bisogna rispondere con un incremento della pressione, e una pressione di questo genere può esistere solo quando il mondo si presenta unito.
Un esempio urgente è lo sforzo per prevenire la diffusione delle armi nucleari e per arrivare a un mondo senza bombe atomiche. A metà del secolo scorso, le nazioni accettarono di essere vincolate da un trattato i cui termini sono chiari: tutti avranno accesso all'energia nucleare a scopi civili, chi non ha armi nucleari rinuncerà ad averle e chi ha armi nucleari si impegnerà a eliminarle. Io mi impegno perché questo trattato sia rispettato. È un punto centrale della mia politica estera e sto lavorando insieme al presidente russo Medvedev per ridurre gli arsenali nucleari in possesso dei nostri due Paesi.
Ma è dovere di tutti noi insistere perché nazioni come l'Iran e la Corea del Nord non giochino d'azzardo col sistema. Chi afferma di rispettare il diritto internazionale non può distogliere lo sguardo quando le sue regole vengono trasgredite apertamente. Chi ha a cuore la propria sicurezza non può ignorare il pericolo di una corsa agli armamenti in Medio Oriente o nell'Asia orientale. Chi cerca la pace non può restarsene inerte mentre altre nazioni si armano per una guerra nucleare.
Lo stesso principio si applica a chi viola il diritto internazionale per brutalizzare il proprio stesso popolo. Il genocidio nel Darfur, gli stupri sistematici nel Congo o la repressione in Birmania non possono rimanere senza conseguenze. E più saremo uniti, meno ci troveremo a dover scegliere fra l'intervento armato e la complicità nell'oppressione.
Questo mi conduce a un secondo punto: il tipo di pace che vogliamo. Perché la pace non è solamente l'assenza di conflitto aperto. Solo una pace giusta basata sui diritti intrinseci e sulla dignità di ogni individuo può essere veramente duratura.
Fu questa l'intuizione alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dopo la seconda guerra mondiale. Sulla scia delle devastazioni lasciate dal conflitto, quelle persone riconobbero che senza protezione dei diritti umani la pace è una promessa vuota.
Eppure troppo spesso queste parole vengono ignorate. In alcuni Paesi, il mancato rispetto dei diritti umani viene giustificato con la falsa tesi che questi princìpi sono figli dell'Occidente e che sono estranei alla cultura locale o a determinate fasi dello sviluppo di una nazione. E all'interno dell'America c'è da tempo tensione fra chi si autodefinisce realista e chi si autodefinisce idealista, una tensione che lascia intendere un'alternativa drastica fra il perseguimento meschino di interessi e una campagna infinita per imporre i nostri valori.
Io rifiuto questa scelta. Sono convinto che la pace è instabile laddove ai cittadini viene negato il diritto di parlare liberamente o di venerare il dio che preferiscono, di scegliere i propri leader o di riunirsi senza pericolo. Il risentimento represso si inasprisce, e la repressione dell'identità tribale o religiosa può produrre violenza. Noi sappiamo che è vero anche il contrario. Solo quando è diventata libera l'Europa ha finalmente trovato la pace. L'America non ha mai combattuto una guerra contro un Paese democratico e i nostri amici più stretti sono governi che proteggono i diritti dei loro cittadini. Negare le aspirazioni degli esseri umani non è nell'interesse dell'America (e nemmeno del mondo), per quanto cinica e ristretta possa essere la definizione di interesse che viene adottata.
Quindi, pur rispettando la cultura specifica e le tradizioni dei diversi Paesi, l'America spezzerà sempre una lancia in favore di quelle aspirazioni che sono universali. Daremo testimonianza della silenziosa dignità di riformatori come Aung San Suu Kyi, del coraggio degli abitanti dello Zimbabwe che vanno a votare nonostante i pestaggi, delle centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato silenziosamente per le strade dell'Iran. È significativo che i leader di questi governi temano più le aspirazioni del loro stesso popolo che il potere di un'altra nazione. Ed è dovere di tutti i popoli liberi e di tutte le nazioni libere far capire a questi movimenti che la speranza e la storia sono dalla loro parte.
Voglio dire anche un'altra cosa: promuovere i diritti umani non può voler dire limitarsi all'esortazione. A volte questa va affiancata da una scrupolosa azione diplomatica. Lo so che trattare con regimi repressivi non consente l'appagante purezza dell'indignazione. Ma so anche che le sanzioni senza la sensibilizzazione - e la condanna senza dialogo - possono produrre un immobilismo disastroso. Nessun regime repressivo sceglierà di percorrere una strada nuova se non gli si lascerà una porta aperta.
Di fronte agli orrori della Rivoluzione Culturale, l'incontro di Nixon con Mao appare imperdonabile, eppure sicuramente quell'incontro ha contribuito a spingere la Cina lungo una strada che ha consentito a milioni di suoi cittadini di uscire dalla povertà e di entrare in contatto con le società aperte. Il dialogo di papa Giovanni Paolo II con il regime polacco ha creato spazi non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per leader sindacali come Lech Walesa. Gli sforzi di Ronald Reagan per la riduzione degli armamenti e l'appoggio alla perestrojka non servirono solo a migliorare i rapporti con l'Unione Sovietica, ma diedero più forza ai dissidenti in tutta l'Europa orientale. Non c'è una formula unica. Dobbiamo fare del nostro meglio per bilanciare isolamento e dialogo, pressioni e incentivi, per favorire il progresso nel tempo dei diritti umani e della dignità.
In terzo luogo, una pace giusta non include solo i diritti civili e politici, deve includere la sicurezza economica e l'opportunità. Perché pace giusta non vuol dire solo libertà dalla paura, ma libertà dal bisogno.
È indubbiamente vero che raramente c'è sviluppo stabile senza sicurezza; è vero anche che la sicurezza non esiste laddove gli esseri umani non hanno accesso a cibo a sufficienza, o all'acqua pulita, o alle medicine di cui hanno bisogno per sopravvivere. Non esiste laddove i bambini non possono aspirare a un'istruzione decente o a un lavoro che permetta di mantenere una famiglia. L'assenza di speranza può corrodere una società dell'interno.
Ecco perché aiutare i contadini a dare da mangiare alla loro famiglia, o aiutare le nazioni a dare un'istruzione ai loro figli e a curare i malati, non è pura e semplice carità. Ecco anche perché il mondo deve unirsi per combattere i cambiamenti climatici. Quasi tutti gli scienziati concordano che se non faremo nulla ci troveremo a fare i conti con altre siccità, altre carestie e altre migrazioni di massa, che alimenteranno altri conflitti per decenni. Per questo non sono solo gli scienziati e gli ambientalisti a chiedere un'azione pronta e decisa, sono i vertici delle forze armate nel mio Paese e in altri Paesi, che capiscono che in palio c'è la sicurezza di tutti.
Accordi fra nazioni. Istituzioni forti. Difesa dei diritti umani. Investimenti nello sviluppo. Sono tutti ingredienti fondamentali per realizzare quell'evoluzione di cui parlava Kennedy. Ma io sono convinto che non avremo la volontà, o la perseveranza, di portare a termine questo compito senza qualcosa di più, e questo qualcosa è l'espansione costante della nostra immaginazione morale, la convinzione che c'è qualcosa di irriducibile che ci accomuna tutti.
Man mano che il mondo diventa più piccolo, dovrebbe diventare più facile per gli esseri umani riconoscere quanto siamo simili, capire che fondamentalmente vogliamo tutti le stesse cose, che speriamo tutti di avere la possibilità di vivere le nostre vite in modo più o meno felice e realizzato, per noi stessi e per le nostre famiglie.
Ma considerando il ritmo forsennato della globalizzazione e il livellamento culturale che porta la modernità, non c'è da sorprendersi che la gente abbia paura di perdere quello che più ama delle proprie identità specifiche, la razza, la tribù e, forse più forte di tutte, la religione. In alcune zone questa paura ha scatenato dei conflitti. A volte sembra addirittura che stiamo facendo dei passi indietro. Lo abbiamo visto in Medio Oriente, con il conflitto fra arabi ed ebrei che sembra inasprirsi. Lo abbiamo visto in nazioni lacerate dalle divisioni tribali.
La cosa più pericolosa è che lo vediamo nel modo in cui viene usata la religione per giustificare l'omicidio di innocenti da parte di chi distorce e svilisce la grande religione islamica, quelli che hanno attaccato il mio Paese dall'Afghanistan. Questi estremisti non sono i primi a uccidere nel nome di Dio: le atrocità delle Crociate sono ben note. Ma ci ricordano che nessuna guerra santa può essere una guerra giusta. Perché se credi veramente di stare eseguendo il volere divino, allora non hai necessità di mostrare alcun ritegno, non hai necessità di risparmiare la donna incinta, o il medico, o addirittura una persona della tua stessa fede. Una visione tanto distorta della religione non è solo incompatibile con il concetto di pace, ma anche con lo scopo della fede, perché l'unica regola fondamentale di ogni religione importante è fare agli altri quello che vorremmo che gli altri facessero a noi.
Rispettare questa legge d'amore è da sempre lo sforzo fondamentale della natura umana. Siamo fallibili. Commettiamo errori e cadiamo vittime delle tentazioni dell'orgoglio, del potere, e talvolta del male. Anche quelli fra noi che sono animati dalle migliori intenzioni possono non mettere riparo a un torto che viene commesso di fronte a loro.
Ma non abbiamo bisogno di pensare che la natura umana sia perfetta per continuare a credere che la condizione umana possa essere perfezionata. Non dobbiamo vivere in un mondo idealizzato per continuare a perseguire quegli ideali che lo renderanno un posto migliore. La nonviolenza praticata da uomini come Gandhi e come Masrtin Luther King forse non è pratica o non è possibile in tutte le circostanze, ma l'amore che loro hanno predicato, la loro fede nel progresso dell'umanità dev'essere sempre la stella polare che ci guida nel nostro viaggio.
Perché se perdiamo questa fede, se la liquidiamo come qualcosa di stupido o ingenuo, se la separiamo dalle decisioni che prendiamo sulla guerra e sulla pace, allora perdiamo quello che c'è di migliore nell'umanità. Perdiamo il nostro senso di possibilità. Perdiamo la nostra bussola morale.
Come hanno fatto altre generazioni prima di noi, dobbiamo rifiutare quel futuro. Come disse Martin Luther King in questa stessa occasione molti anni fa, "io rifiuto di accettare la disperazione come risposta finale alle ambiguità della storia. Rifiuto di accettare l'idea che la presente natura umana, che preferisce 'le cose come stanno' ci renda moralmente incapaci di conseguire l'eterno 'dover essere' con cui dobbiamo sempre confrontarci".
E dunque, sforziamoci di conseguire il mondo che deve essere, quella scintilla del divino che ancora brilla in ognuna delle nostre anime. Da qualche parte oggi, qui e adesso, un soldato vede che il nemico ha più potenza di fuoco, ma tiene la posizione per conservare la pace.
Da qualche parte, oggi, in questo mondo, un giovane manifestante sa che il suo governo reagirà con la forza bruta, ma ha il coraggio di continuare a marciare. Da qualche parte, oggi, una madre che deve fare i conti con una straziante miseria trova ancora il tempo per insegnare al suo bambino, che è convinto che in un mondo crudele ci sia ancora spazio per i suoi sogni.
Dobbiamo vivere secondo il loro esempio. Possiamo riconoscere che l'oppressione non sarà mai sconfitta, ma nonostante questo continuare a lottare per la giustizia. Possiamo ammettere che la depravazione è impossibile da sconfiggere, ma nonostante questo continuare a lottare per la dignità. Possiamo essere consapevoli che ci sarà la guerra, e nonostante questo continuare a lottare per la pace. Possiamo farlo, perché questa è la storia del progresso umano, questa è la speranza di tutto il mondo; e in questo momento di sfide dev'essere il nostro compito, qui sulla Terra.
"Una pace giusta e duratura"
Le parole del presidente degli Stati Uniti in occasione dell'accettazione del premio Nobel per la pace: "A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio i miei successi sono poca cosa"
Vostra maestà, vostra altezza reale, illustri membri del Comitato norvegese per il premio Nobel, cittadini americani e cittadini del mondo intero:
ricevo questo onorificenza con profonda gratitudine e grande umiltà. È un premio che parla alle nostre aspirazioni più alte, che ci dice che, pur con tutta la crudeltà e le difficoltà del nostro mondo, non siamo unicamente prigionieri del fato. Quello che facciamo conta, e possiamo piegare la storia nel senso della giustizia.
Ma sarei negligente se sorvolassi sulle forti polemiche che ha suscitato vostra generosa decisione. In parte queste polemiche nascono dal fatto che io sono all'inizio, e non al termine, delle mie fatiche. A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio - Schweitzer e King, Marshall e Mandela - i miei successi sono poca cosa. E poi ci sono gli uomini e le donne in tutto il mondo che vengono incarcerati e picchiati perché cercano giustizia, ci sono quelli che lavorano duramente nelle organizzazioni umanitarie per alleviare le sofferenze, ci sono quei milioni senza nome che con i loro atti silenziosi di coraggio e di compassione sono di ispirazione anche per il più cinico degli individui. Non posso contestare le ragioni di chi sostiene che questi uomini e queste donne - alcuni noti, altri sconosciuti a chiunque tranne che a quelli che ricevono il loro aiuto - meritano questo riconoscimento molto più di quanto non lo meriti io.
Ma forse il problema maggiore è che io sono il comandante in capo di una nazione impegnata in due guerre. Una di queste guerre sta lentamente esaurendosi. L'altra è un conflitto che l'America non ha cercato, un conflitto a cui prendono parte insieme a noi altri quarantatré Paesi, compresa la Norvegia, nel tentativo di difendere noi stessi e tutte le nazioni da ulteriori attacchi.
Ciò non toglie però che siamo in guerra e che io sono responsabile del dispiegamento sul fronte, in una terra lontana, di migliaia di giovani americani. Alcuni di loro uccideranno. Alcuni saranno uccisi. Per questo vengo qui con l'acuta consapevolezza di quale sia il costo di un conflitto armato, carico di difficili interrogativi sul rapporto fra guerra e pace e sui nostri sforzi per sostituire la prima con la seconda.
Non sono interrogativi nuovi. La guerra, in una forma o nell'altra, ha accompagnato l'uomo fin dalle origini. Agli albori della storia nessuno ne metteva in discussione la moralità: la guerra era semplicemente un fatto, come la siccità o la malattia; era il modo con cui le tribù e poi le civiltà cercavano di acquisire potere e risolvevano le loro divergenze.
Col tempo, mentre i codici giuridici cercavano di mettere sotto controllo la violenza all'interno dei gruppi, filosofi, uomini di chiesa e statisti cercavano di regolamentare la forza distruttiva della guerra. Emerse il concetto di "guerra giusta", che sottintendeva che la guerra è giustificata solo quando rispetta determinate condizioni: e cioè se viene mossa come ultima ratio o per autodifesa, se la forza usata è proporzionata e se, nei limiti del possibile, i civili vengono risparmiati dalle violenze.
Raramente nella storia si è vista una guerra che rispondesse al concetto di guerra giusta. La capacità degli esseri umani di inventare nuovi modi per ammazzarsi a vicenda si è rivelata inesauribile, al pari della nostra capacità di escludere dalla compassione chi ha un aspetto diverso o prega un Dio diverso. Le guerre fra eserciti hanno lasciato il posto alle guerre fra nazioni, guerre totali dove la distinzione fra combattenti e civili diventava meno netta. Nell'arco di trent'anni, per due volte questo continente è precipitato nel gorgo della carneficina. E benché sia difficile immaginare una causa più giusta della sconfitta del Terzo Reich e delle potenze dell'Asse, la seconda guerra mondiale fu un conflitto dove il numero complessivo delle vittime fra i civili superò quello dei soldati caduti.
Sulla scia di una distruzione tanto vasta, e con l'avvento dell'era nucleare, divenne chiaro sia ai vincitori che ai vinti che il mondo aveva bisogno di istituzioni che prevenissero un'altra guerra mondiale. E così, venticinque anni dopo la bocciatura da parte del Senato americano della Lega delle Nazioni (un'idea per la quale Woodrow Wilson vinse questo premio), l'America guidò il mondo alla costruzione di un'architettura per mantenere la pace: il piano Marshall e le Nazioni Unite, strumenti per regolare la guerra, trattati per difendere i diritti dell'uomo, impedire genocidi e limitare le armi più pericolose.
Sotto molti punti di vista, questi sforzi ebbero successo. Sì, sono state combattute guerre terribili e sono state commesse atrocità. Ma non c'è stata nessuna terza guerra mondiale. La guerra fredda si è conclusa con folle entusiaste che distruggevano un muro. I commerci hanno legato insieme gran parte del pianeta. Miliardi di individui sono usciti dalla povertà. Gli ideali di libertà, autodeterminazione, uguaglianza e Stato di diritto si sono fatti timidamente strada. Noi siamo gli eredi della forza d'animo e della lungimiranza delle generazioni passate, ed è un'eredità di cui il mio Paese va giustamente fiero.
Ora che è passato un decennio dall'inizio del nuovo secolo, questa vecchia architettura comincia a cedere sotto il peso di nuove minacce. Il mondo forse non trema più al pensiero di una guerra fra due superpotenze nucleari, ma la proliferazione delle armi nucleari rischia di rendere più probabile una catastrofe. Il terrorismo è un'arma tattica usata da molto tempo, ma la tecnologia moderna consente a pochi, piccoli uomini con una rabbia smisurata di assassinare un numero terrificante di innocenti.
Inoltre, le guerre fra nazioni sono sostituite sempre più dalle guerre all'interno delle nazioni. La resurrezione di conflitti etnici o settari, la crescita di movimenti secessionistici, guerriglie e Stati allo sbando intrappolano sempre di più i civili in un caos senza fine. Nelle guerre odierne vengono uccisi molti più civili che soldati: si gettano i semi di conflitti futuri, si devasta l'economia, si lacera la società civile, si accumulano i profughi e si lasciano segni indelebili sui bambini.
Non ho qui con me, oggi, una soluzione definitiva ai problemi della guerra. Quello che so è che per affrontare queste sfide servirà la stessa capacità di visione, lo stesso duro lavoro, la stessa perseveranza di quegli uomini e di quelle donne che alcuni decenni fa hanno agito con tanto coraggio. E servirà un ripensamento dei concetti della guerra giusta e degli imperativi di una pace giusta.
Dobbiamo partire della consapevolezza di una verità difficile da mandare giù: non riusciremo a sradicare il conflitto violento nel corso della nostra vita. Ci saranno occasioni in cui le nazioni, agendo individualmente o collettivamente, troveranno non solo necessario, ma moralmente giustificato l'uso della forza.
Dico questa cosa pensando a quello che disse anni fa, in questa stessa cerimonia, Martin Luther King: "La violenza non porta mai una pace permanente. Non risolve nessun problema della società, anzi ne crea di nuovi e più complicati". Io, che sono qui come conseguenza diretta dell'opera di una vita del reverendo King, sono la testimonianza vivente della forza morale della nonviolenza. Io so che non c'è nulla di debole, nulla di passivo, nulla di ingenuo, nelle idee e nella vita di Gandhi e di Martin Luther King.
Ma in quanto capo di Stato che ha giurato di proteggere e difendere la mia nazione non posso lasciarmi guidare solo dai loro esempi. Devo affrontare il mondo così com'è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano. Perché una cosa dev'essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda a deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un'invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le imperfezioni dell'uomo e i limiti della ragione.
Sollevo questo punto perché in molti Paesi oggi c'è una profonda ambivalenza sulle azioni militari, qualunque sia la causa che le muove. In certi casi, a questa ambivalenza si aggiunge una diffidenza istintiva nei confronti dell'America, l'unica superpotenza militare del pianeta.
Ma il mondo deve ricordarsi che non sono state solo le istituzioni internazionali, non sono stati solo i trattati e le dichiarazioni a portare stabilità al pianeta dopo la fine della seconda guerra mondiale. A prescindere dagli errori che abbiamo commesso, il dato di fatto puro e semplice è questo: gli Stati Uniti d'America hanno contribuito per più di sessant'anni a proteggere la sicurezza globale, con il sangue dei nostri cittadini e la forza delle nostre armi. Lo spirito di servizio e di sacrificio dei nostri uomini e donne in uniforme ha promosso la pace e la prosperità, dalla Germania alla Corea, e ha consentito alla democrazia di insediarsi in luoghi come i Balcani. Abbiamo sopportato questo fardello non perché cerchiamo di imporre la nostra volontà. Lo abbiamo fatto per interesse illuminato, perché cerchiamo un futuro migliore per i nostri figli e nipoti, e siamo convinti che la loro vita sarà migliore se altri figli e nipoti potranno vivere in libertà e prosperità.
Dunque sì, gli strumenti della guerra contribuiscono a preservare la pace. Ma questa verità deve coesistere con un'altra, e cioè che la guerra, per quanto giustificata possa essere, porterà sicuramente con sé tragedie umane. C'è gloria nel coraggio e nel sacrificio di un soldato, c'è l'espressione di una devozione per il proprio Paese, per la causa e per i commilitoni. Ma la guerra in sé non è mai gloriosa e non dobbiamo mai sbandierarla come tale.
La nostra sfida dunque consiste in parte nel riconciliare queste due verità apparentemente inconciliabili. La guerra a volte è necessaria e la guerra è, a un certo livello, espressione di sentimenti umani. Concretamente, dobbiamo indirizzare i nostri sforzi al compito che il presidente Kennedy invocava molto tempo fa. "Concentriamoci", diceva lui, "su una pace più pratica, più raggiungibile, basata non su un improvviso capovolgimento della natura umana, ma su una graduale evoluzione delle istituzioni umane".
Come dovrebbe essere questa evoluzione? Quali potrebbero essere queste misure pratiche?
Per cominciare, io sono convinto che tutte le nazioni, sia le nazioni forti che le nazioni deboli, devono aderire a dei parametri per regolare l'uso della forza. Io, come ogni capo di Stato, mi riservo il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per difendere la mia nazione. Resto tuttavia convinto che aderire a delle regole sia qualcosa che dà maggior forza a chi lo fa e che isola - e indebolisce - chi non lo fa.
Il mondo si è stretto intorno all'America dopo gli attacchi dell'11 settembre e continua a sostenere i nostri sforzi in Afghanistan in virtù dell'orrore suscitato da quegli attacchi insensati e del principio riconosciuto dell'autodifesa. Allo stesso modo, il mondo ha riconosciuto la necessità di affrontare Saddam Hussein quando questi invase il Kuwait, un consenso che inviò un messaggio chiaro a tutti sul prezzo che devi pagare se vuoi compiere un'aggressione.
L'America non può pretendere che gli altri rispettino le regole della strada se lei si rifiuta di rispettarle. Perché quando non lo facciamo le nostre azioni appaiono arbitrarie e minano la legittimità di interventi futuri, non importa se giustificati o meno.
Questo diventa particolarmente importante quando lo scopo dell'azione militare va al di là dell'autodifesa o della difesa di una nazione da un aggressore. Tutti siamo alle prese sempre di più con difficili interrogativi su come impedire massacri di civili da parte del loro stesso governo, o su come fermare una guerra civile che rischia di risucchiare nelle violenze e nelle sofferenze un'intera regione.
Io sono convinto che l'uso della forza possa essere giustificato per ragioni umanitarie, come è stato nei Balcani o in altri posti segnati dalla guerra. Restare a guardare lacera la nostra coscienza e può condurre a interventi più costosi in un secondo momento. Ecco perché tutte le nazioni responsabili devono accettare il ruolo che possono giocare le forze armate, con un mandato chiaro, per il mantenimento della pace.
L'impegno dell'America nei confronti della sicurezza del mondo non verrà mai meno. Ma in un mondo dove le minacce sono più diffuse, e le missioni più complesse, l'America non può agire da sola. Questo vale per l'Afghanistan. Questo vale per Stati allo sbando come la Somalia, dove il terrorismo e la pirateria si accompagnano a fame e sofferenze. E purtroppo continuerà a valere ancora per anni a venire nelle regioni instabili.
I dirigenti e i soldati dei Paesi della Nato, e di altri Paesi amici e alleati, dimostrano questa verità attraverso la capacità e il coraggio di cui hanno dato prova in Afghanistan. Ma in molti Paesi c'è uno scollamento fra gli sforzi delle truppe e l'ambivalenza della cittadinanza. Io capisco i motivi dell'impopolarità della guerra. Ma so anche questo: pensare che la pace sia auspicabile di solito non basta per ottenere la pace. La pace richiede responsabilità. La pace comporta sacrificio. Ecco perché la Nato resta indispensabile. Ecco perché dobbiamo rafforzare le operazioni di peacekeeping dell'Onu e regionali, e non lasciare che siano pochi Paesi a farsene carico. Ecco perché rendiamo omaggio a chi ritorna a casa da operazioni di peacekeeping e addestramento, a Oslo e a Roma, a Ottawa e a Sydney, a Dacca e a Kigali: rendiamo omaggio a queste persone non come costruttori di guerra, ma come edificatori di pace.
Voglio dire un'ultima cosa sull'uso della forza. Anche quando prendiamo la difficile decisione di cominciare una guerra, dobbiamo pensare chiaramente a come questa guerra va combattuta. Il Comitato per il Nobel lo riconobbe assegnando il primo Nobel per la pace a Henry Dunant, il fondatore della Croce rossa e uno dei principali promotori delle Convenzioni di Ginevra.
Laddove è necessario usare la forza, abbiamo un interesse morale e strategico ad attenerci a determinate regole di comportamento. E anche quando affrontiamo un avversario crudele, che non rispetta nessuna regola, sono convinto che gli Stati Uniti debbano continuare a farsene portatori. È questo che ci rende diversi da coloro che combattiamo. È anche da qui che ricaviamo la nostra forza. È per questo che ho vietato la tortura. È per questo che ho ordinato la chiusura della prigione di Guantánamo. Ed è per questo che ho riaffermato l'impegno dell'America al rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Perdiamo noi stessi quando scendiamo a compromessi proprio su quegli ideali che lottiamo per difendere. E onoriamo quegli ideali se li rispettiamo non soltanto quando è facile farlo, ma anche quando è difficile.
Ho parlato degli interrogativi che dobbiamo tenere presenti nel cuore e nella mente quando scegliamo di muovere guerra. Ma ora voglio soffermarmi sugli sforzi che possiamo fare per evitare scelte tanto tragiche, e voglio parlare di tre vie per costruire una pace giusta e duratura.
La prima riguarda l'approccio da adottare nei confronti di quelle nazioni che violano le regole e le leggi: sono convinto che dobbiamo sviluppare alternative alla violenza che siano sufficientemente efficaci da modificare i comportamenti, perché se vogliamo una pace duratura allora le parole della comunità internazionale devono avere un significato. Quei regimi che violano le regole devono essere chiamati a risponderne. Le sanzioni devono essere realmente incisive. All'intransigenza bisogna rispondere con un incremento della pressione, e una pressione di questo genere può esistere solo quando il mondo si presenta unito.
Un esempio urgente è lo sforzo per prevenire la diffusione delle armi nucleari e per arrivare a un mondo senza bombe atomiche. A metà del secolo scorso, le nazioni accettarono di essere vincolate da un trattato i cui termini sono chiari: tutti avranno accesso all'energia nucleare a scopi civili, chi non ha armi nucleari rinuncerà ad averle e chi ha armi nucleari si impegnerà a eliminarle. Io mi impegno perché questo trattato sia rispettato. È un punto centrale della mia politica estera e sto lavorando insieme al presidente russo Medvedev per ridurre gli arsenali nucleari in possesso dei nostri due Paesi.
Ma è dovere di tutti noi insistere perché nazioni come l'Iran e la Corea del Nord non giochino d'azzardo col sistema. Chi afferma di rispettare il diritto internazionale non può distogliere lo sguardo quando le sue regole vengono trasgredite apertamente. Chi ha a cuore la propria sicurezza non può ignorare il pericolo di una corsa agli armamenti in Medio Oriente o nell'Asia orientale. Chi cerca la pace non può restarsene inerte mentre altre nazioni si armano per una guerra nucleare.
Lo stesso principio si applica a chi viola il diritto internazionale per brutalizzare il proprio stesso popolo. Il genocidio nel Darfur, gli stupri sistematici nel Congo o la repressione in Birmania non possono rimanere senza conseguenze. E più saremo uniti, meno ci troveremo a dover scegliere fra l'intervento armato e la complicità nell'oppressione.
Questo mi conduce a un secondo punto: il tipo di pace che vogliamo. Perché la pace non è solamente l'assenza di conflitto aperto. Solo una pace giusta basata sui diritti intrinseci e sulla dignità di ogni individuo può essere veramente duratura.
Fu questa l'intuizione alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dopo la seconda guerra mondiale. Sulla scia delle devastazioni lasciate dal conflitto, quelle persone riconobbero che senza protezione dei diritti umani la pace è una promessa vuota.
Eppure troppo spesso queste parole vengono ignorate. In alcuni Paesi, il mancato rispetto dei diritti umani viene giustificato con la falsa tesi che questi princìpi sono figli dell'Occidente e che sono estranei alla cultura locale o a determinate fasi dello sviluppo di una nazione. E all'interno dell'America c'è da tempo tensione fra chi si autodefinisce realista e chi si autodefinisce idealista, una tensione che lascia intendere un'alternativa drastica fra il perseguimento meschino di interessi e una campagna infinita per imporre i nostri valori.
Io rifiuto questa scelta. Sono convinto che la pace è instabile laddove ai cittadini viene negato il diritto di parlare liberamente o di venerare il dio che preferiscono, di scegliere i propri leader o di riunirsi senza pericolo. Il risentimento represso si inasprisce, e la repressione dell'identità tribale o religiosa può produrre violenza. Noi sappiamo che è vero anche il contrario. Solo quando è diventata libera l'Europa ha finalmente trovato la pace. L'America non ha mai combattuto una guerra contro un Paese democratico e i nostri amici più stretti sono governi che proteggono i diritti dei loro cittadini. Negare le aspirazioni degli esseri umani non è nell'interesse dell'America (e nemmeno del mondo), per quanto cinica e ristretta possa essere la definizione di interesse che viene adottata.
Quindi, pur rispettando la cultura specifica e le tradizioni dei diversi Paesi, l'America spezzerà sempre una lancia in favore di quelle aspirazioni che sono universali. Daremo testimonianza della silenziosa dignità di riformatori come Aung San Suu Kyi, del coraggio degli abitanti dello Zimbabwe che vanno a votare nonostante i pestaggi, delle centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato silenziosamente per le strade dell'Iran. È significativo che i leader di questi governi temano più le aspirazioni del loro stesso popolo che il potere di un'altra nazione. Ed è dovere di tutti i popoli liberi e di tutte le nazioni libere far capire a questi movimenti che la speranza e la storia sono dalla loro parte.
Voglio dire anche un'altra cosa: promuovere i diritti umani non può voler dire limitarsi all'esortazione. A volte questa va affiancata da una scrupolosa azione diplomatica. Lo so che trattare con regimi repressivi non consente l'appagante purezza dell'indignazione. Ma so anche che le sanzioni senza la sensibilizzazione - e la condanna senza dialogo - possono produrre un immobilismo disastroso. Nessun regime repressivo sceglierà di percorrere una strada nuova se non gli si lascerà una porta aperta.
Di fronte agli orrori della Rivoluzione Culturale, l'incontro di Nixon con Mao appare imperdonabile, eppure sicuramente quell'incontro ha contribuito a spingere la Cina lungo una strada che ha consentito a milioni di suoi cittadini di uscire dalla povertà e di entrare in contatto con le società aperte. Il dialogo di papa Giovanni Paolo II con il regime polacco ha creato spazi non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per leader sindacali come Lech Walesa. Gli sforzi di Ronald Reagan per la riduzione degli armamenti e l'appoggio alla perestrojka non servirono solo a migliorare i rapporti con l'Unione Sovietica, ma diedero più forza ai dissidenti in tutta l'Europa orientale. Non c'è una formula unica. Dobbiamo fare del nostro meglio per bilanciare isolamento e dialogo, pressioni e incentivi, per favorire il progresso nel tempo dei diritti umani e della dignità.
In terzo luogo, una pace giusta non include solo i diritti civili e politici, deve includere la sicurezza economica e l'opportunità. Perché pace giusta non vuol dire solo libertà dalla paura, ma libertà dal bisogno.
È indubbiamente vero che raramente c'è sviluppo stabile senza sicurezza; è vero anche che la sicurezza non esiste laddove gli esseri umani non hanno accesso a cibo a sufficienza, o all'acqua pulita, o alle medicine di cui hanno bisogno per sopravvivere. Non esiste laddove i bambini non possono aspirare a un'istruzione decente o a un lavoro che permetta di mantenere una famiglia. L'assenza di speranza può corrodere una società dell'interno.
Ecco perché aiutare i contadini a dare da mangiare alla loro famiglia, o aiutare le nazioni a dare un'istruzione ai loro figli e a curare i malati, non è pura e semplice carità. Ecco anche perché il mondo deve unirsi per combattere i cambiamenti climatici. Quasi tutti gli scienziati concordano che se non faremo nulla ci troveremo a fare i conti con altre siccità, altre carestie e altre migrazioni di massa, che alimenteranno altri conflitti per decenni. Per questo non sono solo gli scienziati e gli ambientalisti a chiedere un'azione pronta e decisa, sono i vertici delle forze armate nel mio Paese e in altri Paesi, che capiscono che in palio c'è la sicurezza di tutti.
Accordi fra nazioni. Istituzioni forti. Difesa dei diritti umani. Investimenti nello sviluppo. Sono tutti ingredienti fondamentali per realizzare quell'evoluzione di cui parlava Kennedy. Ma io sono convinto che non avremo la volontà, o la perseveranza, di portare a termine questo compito senza qualcosa di più, e questo qualcosa è l'espansione costante della nostra immaginazione morale, la convinzione che c'è qualcosa di irriducibile che ci accomuna tutti.
Man mano che il mondo diventa più piccolo, dovrebbe diventare più facile per gli esseri umani riconoscere quanto siamo simili, capire che fondamentalmente vogliamo tutti le stesse cose, che speriamo tutti di avere la possibilità di vivere le nostre vite in modo più o meno felice e realizzato, per noi stessi e per le nostre famiglie.
Ma considerando il ritmo forsennato della globalizzazione e il livellamento culturale che porta la modernità, non c'è da sorprendersi che la gente abbia paura di perdere quello che più ama delle proprie identità specifiche, la razza, la tribù e, forse più forte di tutte, la religione. In alcune zone questa paura ha scatenato dei conflitti. A volte sembra addirittura che stiamo facendo dei passi indietro. Lo abbiamo visto in Medio Oriente, con il conflitto fra arabi ed ebrei che sembra inasprirsi. Lo abbiamo visto in nazioni lacerate dalle divisioni tribali.
La cosa più pericolosa è che lo vediamo nel modo in cui viene usata la religione per giustificare l'omicidio di innocenti da parte di chi distorce e svilisce la grande religione islamica, quelli che hanno attaccato il mio Paese dall'Afghanistan. Questi estremisti non sono i primi a uccidere nel nome di Dio: le atrocità delle Crociate sono ben note. Ma ci ricordano che nessuna guerra santa può essere una guerra giusta. Perché se credi veramente di stare eseguendo il volere divino, allora non hai necessità di mostrare alcun ritegno, non hai necessità di risparmiare la donna incinta, o il medico, o addirittura una persona della tua stessa fede. Una visione tanto distorta della religione non è solo incompatibile con il concetto di pace, ma anche con lo scopo della fede, perché l'unica regola fondamentale di ogni religione importante è fare agli altri quello che vorremmo che gli altri facessero a noi.
Rispettare questa legge d'amore è da sempre lo sforzo fondamentale della natura umana. Siamo fallibili. Commettiamo errori e cadiamo vittime delle tentazioni dell'orgoglio, del potere, e talvolta del male. Anche quelli fra noi che sono animati dalle migliori intenzioni possono non mettere riparo a un torto che viene commesso di fronte a loro.
Ma non abbiamo bisogno di pensare che la natura umana sia perfetta per continuare a credere che la condizione umana possa essere perfezionata. Non dobbiamo vivere in un mondo idealizzato per continuare a perseguire quegli ideali che lo renderanno un posto migliore. La nonviolenza praticata da uomini come Gandhi e come Masrtin Luther King forse non è pratica o non è possibile in tutte le circostanze, ma l'amore che loro hanno predicato, la loro fede nel progresso dell'umanità dev'essere sempre la stella polare che ci guida nel nostro viaggio.
Perché se perdiamo questa fede, se la liquidiamo come qualcosa di stupido o ingenuo, se la separiamo dalle decisioni che prendiamo sulla guerra e sulla pace, allora perdiamo quello che c'è di migliore nell'umanità. Perdiamo il nostro senso di possibilità. Perdiamo la nostra bussola morale.
Come hanno fatto altre generazioni prima di noi, dobbiamo rifiutare quel futuro. Come disse Martin Luther King in questa stessa occasione molti anni fa, "io rifiuto di accettare la disperazione come risposta finale alle ambiguità della storia. Rifiuto di accettare l'idea che la presente natura umana, che preferisce 'le cose come stanno' ci renda moralmente incapaci di conseguire l'eterno 'dover essere' con cui dobbiamo sempre confrontarci".
E dunque, sforziamoci di conseguire il mondo che deve essere, quella scintilla del divino che ancora brilla in ognuna delle nostre anime. Da qualche parte oggi, qui e adesso, un soldato vede che il nemico ha più potenza di fuoco, ma tiene la posizione per conservare la pace.
Da qualche parte, oggi, in questo mondo, un giovane manifestante sa che il suo governo reagirà con la forza bruta, ma ha il coraggio di continuare a marciare. Da qualche parte, oggi, una madre che deve fare i conti con una straziante miseria trova ancora il tempo per insegnare al suo bambino, che è convinto che in un mondo crudele ci sia ancora spazio per i suoi sogni.
Dobbiamo vivere secondo il loro esempio. Possiamo riconoscere che l'oppressione non sarà mai sconfitta, ma nonostante questo continuare a lottare per la giustizia. Possiamo ammettere che la depravazione è impossibile da sconfiggere, ma nonostante questo continuare a lottare per la dignità. Possiamo essere consapevoli che ci sarà la guerra, e nonostante questo continuare a lottare per la pace. Possiamo farlo, perché questa è la storia del progresso umano, questa è la speranza di tutto il mondo; e in questo momento di sfide dev'essere il nostro compito, qui sulla Terra.

szwaby82- Messaggi : 4159
Data d'iscrizione : 10.10.11
 Re: Discorso per la pace di Obama ,dicembre 2009
Re: Discorso per la pace di Obama ,dicembre 2009
Barack Obama right
Your majesties, your royal highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America and citizens of the world:
I receive this honor with deep gratitude and great humility. It is an award that speaks to our highest aspirations -- that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate. Our actions matter, and can bend history in the direction of justice.
And yet I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated. In part, this is because I am at the beginning, and not the end, of my labors on the world stage. Compared to some of the giants of history who have received this prize -- Schweitzer and King; Marshall and Mandela -- my accomplishments are slight. And then there are the men and women around the world who have been jailed and beaten in the pursuit of justice; those who toil in humanitarian organizations to relieve suffering; the unrecognized millions whose quiet acts of courage and compassion inspire even the most hardened of cynics. I cannot argue with those who find these men and women -- some known, some obscure to all but those they help -- to be far more deserving of this honor than I.
But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the commander in chief of a nation in the midst of two wars. One of these wars is winding down. The other is a conflict that America did not seek; one in which we are joined by forty-three other countries -- including Norway -- in an effort to defend ourselves and all nations from further attacks
Still, we are at war, and I am responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. Some will kill. Some will be killed. And so I come here with an acute sense of the cost of armed conflict -- filled with difficult questions about the relationship between war and peace, and our effort to replace one with the other.
These questions are not new. War, in one form or another, appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned; it was simply a fact, like drought or disease -- the manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences.
Over time, as codes of law sought to control violence within groups, so did philosophers, clerics and statesmen seek to regulate the destructive power of war. The concept of a "just war" emerged, suggesting that war is justified only when it meets certain preconditions: if it is waged as a last resort or in self-defense; if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence.
For most of history, this concept of just war was rarely observed. The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different God. Wars between armies gave way to wars between nations -- total wars in which the distinction between combatant and civilian became blurred. In the span of 30 years, such carnage would twice engulf this continent. And while it is hard to conceive of a cause more just than the defeat of the Third Reich and the Axis powers, World War II was a conflict in which the total number of civilians who died exceeded the number of soldiers who perished.
In the wake of such destruction, and with the advent of the nuclear age, it became clear to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another World War. And so, a quarter century after the United States Senate rejected the League of Nations -- an idea for which Woodrow Wilson received this prize -- America led the world in constructing an architecture to keep the peace: a Marshall Plan and a United Nations, mechanisms to govern the waging of war, treaties to protect human rights, prevent genocide and restrict the most dangerous weapons.
In many ways, these efforts succeeded. Yes, terrible wars have been fought, and atrocities committed. But there has been no Third World War. The Cold War ended with jubilant crowds dismantling a wall. Commerce has stitched much of the world together. Billions have been lifted from poverty. The ideals of liberty, self-determination, equality and the rule of law have haltingly advanced. We are the heirs of the fortitude and foresight of generations past, and it is a legacy for which my own country is rightfully proud.
A decade into a new century, this old architecture is buckling under the weight of new threats. The world may no longer shudder at the prospect of war between two nuclear superpowers, but proliferation may increase the risk of catastrophe. Terrorism has long been a tactic, but modern technology allows a few small men with outsized rage to murder innocents on a horrific scale.
Moreover, wars between nations have increasingly given way to wars within nations. The resurgence of ethnic or sectarian conflicts; the growth of secessionist movements, insurgencies, and failed states; have increasingly trapped civilians in unending chaos. In today's wars, many more civilians are killed than soldiers; the seeds of future conflict are sewn, economies are wrecked, civil societies torn asunder, refugees amassed and children scarred.
I do not bring with me today a definitive solution to the problems of war. What I do know is that meeting these challenges will require the same vision, hard work and persistence of those men and women who acted so boldly decades ago. And it will require us to think in new ways about the notions of just war and the imperatives of a just peace.
We must begin by acknowledging the hard truth that we will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations -- acting individually or in concert -- will find the use of force not only necessary but morally justified.
I make this statement mindful of what Martin Luther King said in this same ceremony years ago -- "Violence never brings permanent peace. It solves no social problem: it merely creates new and more complicated ones." As someone who stands here as a direct consequence of Dr. King's life's work, I am living testimony to the moral force of nonviolence. I know there is nothing weak -- nothing passive -- nothing naive -- in the creed and lives of Gandhi and King.
But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism -- it is a recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason.
To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism -- it is a recognition of history.
I raise this point because in many countries there is a deep ambivalence about military action today, no matter the cause. At times, this is joined by a reflexive suspicion of America, the world's sole military superpower.
Yet the world must remember that it was not simply international institutions -- not just treaties and declarations -- that brought stability to a post-World War II world. Whatever mistakes we have made, the plain fact is this: The United States of America has helped underwrite global security for more than six decades with the blood of our citizens and the strength of our arms. The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea, and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. We have borne this burden not because we seek to impose our will. We have done so out of enlightened self-interest -- because we seek a better future for our children and grandchildren, and we believe that their lives will be better if other peoples' children and grandchildren can live in freedom and prosperity.
So yes, the instruments of war do have a role to play in preserving the peace. And yet this truth must coexist with another -- that no matter how justified, war promises human tragedy. The soldier's courage and sacrifice is full of glory, expressing devotion to country, to cause and to comrades in arms. But war itself is never glorious, and we must never trumpet it as such.
So part of our challenge is reconciling these two seemingly irreconcilable truths -- that war is sometimes necessary, and war is at some level an expression of human feelings. Concretely, we must direct our effort to the task that President Kennedy called for long ago. "Let us focus," he said, "on a more practical, more attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature but on a gradual evolution in human institutions."
What might this evolution look like? What might these practical steps be?
To begin with, I believe that all nations -- strong and weak alike -- must adhere to standards that govern the use of force. I -- like any head of state -- reserve the right to act unilaterally if necessary to defend my nation. Nevertheless, I am convinced that adhering to standards strengthens those who do, and isolates -- and weakens -- those who don't.
The world rallied around America after the 9/11 attacks, and continues to support our efforts in Afghanistan, because of the horror of those senseless attacks and the recognized principle of self-defense. Likewise, the world recognized the need to confront Saddam Hussein when he invaded Kuwait -- a consensus that sent a clear message to all about the cost of aggression.
Furthermore, America cannot insist that others follow the rules of the road if we refuse to follow them ourselves. For when we don't, our action can appear arbitrary, and undercut the legitimacy of future intervention -- no matter how justified.
This becomes particularly important when the purpose of military action extends beyond self-defense or the defense of one nation against an aggressor. More and more, we all confront difficult questions about how to prevent the slaughter of civilians by their own government, or to stop a civil war whose violence and suffering can engulf an entire region.
I believe that force can be justified on humanitarian grounds, as it was in the Balkans, or in other places that have been scarred by war. Inaction tears at our conscience and can lead to more costly intervention later. That is why all responsible nations must embrace the role that militaries with a clear mandate can play to keep the peace.
America's commitment to global security will never waiver. But in a world in which threats are more diffuse, and missions more complex, America cannot act alone. This is true in Afghanistan. This is true in failed states like Somalia, where terrorism and piracy is joined by famine and human suffering. And sadly, it will continue to be true in unstable regions for years to come.
The leaders and soldiers of NATO countries -- and other friends and allies -- demonstrate this truth through the capacity and courage they have shown in Afghanistan. But in many countries, there is a disconnect between the efforts of those who serve and the ambivalence of the broader public. I understand why war is not popular. But I also know this: The belief that peace is desirable is rarely enough to achieve it. Peace requires responsibility. Peace entails sacrifice. That is why NATO continues to be indispensable. That is why we must strengthen U.N. and regional peacekeeping, and not leave the task to a few countries. That is why we honor those who return home from peacekeeping and training abroad to Oslo and Rome; to Ottawa and Sydney; to Dhaka and Kigali -- we honor them not as makers of war, but as wagers of peace.
Let me make one final point about the use of force. Even as we make difficult decisions about going to war, we must also think clearly about how we fight it. The Nobel Committee recognized this truth in awarding its first prize for peace to Henry Dunant -- the founder of the Red Cross, and a driving force behind the Geneva Conventions.
Where force is necessary, we have a moral and strategic interest in binding ourselves to certain rules of conduct. And even as we confront a vicious adversary that abides by no rules, I believe that the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different from those whom we fight. That is a source of our strength. That is why I prohibited torture. That is why I ordered the prison at Guantanamo Bay closed. And that is why I have reaffirmed America's commitment to abide by the Geneva Conventions. We lose ourselves when we compromise the very ideals that we fight to defend. And we honor those ideals by upholding them not just when it is easy, but when it is hard.
I have spoken to the questions that must weigh on our minds and our hearts as we choose to wage war. But let me turn now to our effort to avoid such tragic choices, and speak of three ways that we can build a just and lasting peace.
First, in dealing with those nations that break rules and laws, I believe that we must develop alternatives to violence that are tough enough to change behavior -- for if we want a lasting peace, then the words of the international community must mean something. Those regimes that break the rules must be held accountable. Sanctions must exact a real price. Intransigence must be met with increased pressure -- and such pressure exists only when the world stands together as one.
One urgent example is the effort to prevent the spread of nuclear weapons, and to seek a world without them. In the middle of the last century, nations agreed to be bound by a treaty whose bargain is clear: All will have access to peaceful nuclear power; those without nuclear weapons will forsake them; and those with nuclear weapons will work toward disarmament. I am committed to upholding this treaty. It is a centerpiece of my foreign policy. And I am working with President [Dmitry] Medvedev to reduce America and Russia's nuclear stockpiles.
But it is also incumbent upon all of us to insist that nations like Iran and North Korea do not game the system. Those who claim to respect international law cannot avert their eyes when those laws are flouted. Those who care for their own security cannot ignore the danger of an arms race in the Middle East or East Asia. Those who seek peace cannot stand idly by as nations arm themselves for nuclear war.
The same principle applies to those who violate international law by brutalizing their own people. When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma -- there must be consequences. And the closer we stand together, the less likely we will be faced with the choice between armed intervention and complicity in oppression.
This brings me to a second point -- the nature of the peace that we seek. For peace is not merely the absence of visible conflict. Only a just peace based upon the inherent rights and dignity of every individual can truly be lasting.
It was this insight that drove drafters of the Universal Declaration of Human Rights after the Second World War. In the wake of devastation, they recognized that if human rights are not protected, peace is a hollow promise.
And yet all too often, these words are ignored. In some countries, the failure to uphold human rights is excused by the false suggestion that these are Western principles, foreign to local cultures or stages of a nation's development. And within America, there has long been a tension between those who describe themselves as realists or idealists -- a tension that suggests a stark choice between the narrow pursuit of interests or an endless campaign to impose our values.
I reject this choice. I believe that peace is unstable where citizens are denied the right to speak freely or worship as they please; choose their own leaders or assemble without fear. Pent-up grievances fester, and the suppression of tribal and religious identity can lead to violence. We also know that the opposite is true. Only when Europe became free did it finally find peace. America has never fought a war against a democracy, and our closest friends are governments that protect the rights of their citizens. No matter how callously defined, neither America's interests -- nor the world's -- are served by the denial of human aspirations.
So even as we respect the unique culture and traditions of different countries, America will always be a voice for those aspirations that are universal. We will bear witness to the quiet dignity of reformers like Aung San Suu Kyi; to the bravery of Zimbabweans who cast their ballots in the face of beatings; to the hundreds of thousands who have marched silently through the streets of Iran. It is telling that the leaders of these governments fear the aspirations of their own people more than the power of any other nation. And it is the responsibility of all free people and free nations to make clear to these movements that hope and history are on their side
Let me also say this: The promotion of human rights cannot be about exhortation alone. At times, it must be coupled with painstaking diplomacy. I know that engagement with repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation. But I also know that sanctions without outreach -- and condemnation without discussion -- can carry forward a crippling status quo. No repressive regime can move down a new path unless it has the choice of an open door.
In light of the Cultural Revolution's horrors, Nixon's meeting with Mao appeared inexcusable -- and yet it surely helped set China on a path where millions of its citizens have been lifted from poverty, and connected to open societies. Pope John Paul's engagement with Poland created space not just for the Catholic Church, but for labor leaders like Lech Walesa. Ronald Reagan's efforts on arms control and embrace of perestroika not only improved relations with the Soviet Union, but empowered dissidents throughout Eastern Europe. There is no simple formula here. But we must try as best we can to balance isolation and engagement; pressure and incentives, so that human rights and dignity are advanced over time.
Third, a just peace includes not only civil and political rights -- it must encompass economic security and opportunity. For true peace is not just freedom from fear, but freedom from want.
It is undoubtedly true that development rarely takes root without security; it is also true that security does not exist where human beings do not have access to enough food, or clean water, or the medicine they need to survive. It does not exist where children cannot aspire to a decent education or a job that supports a family. The absence of hope can rot a society from within.
And that is why helping farmers feed their own people -- or nations educate their children and care for the sick -- is not mere charity. It is also why the world must come together to confront climate change. There is little scientific dispute that if we do nothing, we will face more drought, famine and mass displacement that will fuel more conflict for decades. For this reason, it is not merely scientists and activists who call for swift and forceful action -- it is military leaders in my country and others who understand that our common security hangs in the balance.
Agreements among nations. Strong institutions. Support for human rights. Investments in development. All of these are vital ingredients in bringing about the evolution that President Kennedy spoke about. And yet, I do not believe that we will have the will, or the staying power, to complete this work without something more -- and that is the continued expansion of our moral imagination; an insistence that there is something irreducible that we all share.
As the world grows smaller, you might think it would be easier for human beings to recognize how similar we are; to understand that we all basically want the same things; that we all hope for the chance to live out our lives with some measure of happiness and fulfillment for ourselves and our families.
And yet, given the dizzying pace of globalization, and the cultural leveling of modernity, it should come as no surprise that people fear the loss of what they cherish about their particular identities -- their race, their tribe, and perhaps most powerfully their religion. In some places, this fear has led to conflict. At times, it even feels like we are moving backwards. We see it in Middle East, as the conflict between Arabs and Jews seems to harden. We see it in nations that are torn asunder by tribal lines.
Most dangerously, we see it in the way that religion is used to justify the murder of innocents by those who have distorted and defiled the great religion of Islam, and who attacked my country from Afghanistan. These extremists are not the first to kill in the name of God; the cruelties of the Crusades are amply recorded. But they remind us that no Holy War can ever be a just war. For if you truly believe that you are carrying out divine will, then there is no need for restraint -- no need to spare the pregnant mother, or the medic, or even a person of one's own faith. Such a warped view of religion is not just incompatible with the concept of peace, but the purpose of faith -- for the one rule that lies at the heart of every major religion is that we do unto others as we would have them do unto us.
Adhering to this law of love has always been the core struggle of human nature. We are fallible. We make mistakes, and fall victim to the temptations of pride, and power, and sometimes http://michaeljackson.forumup.it/images/smiles/motocanaglia_fuoco.gif. Even those of us with the best intentions will at times fail to right the wrongs before us.
But we do not have to think that human nature is perfect for us to still believe that the human condition can be perfected. We do not have to live in an idealized world to still reach for those ideals that will make it a better place. The nonviolence practiced by men like Gandhi and King may not have been practical or possible in every circumstance, but the love that they preached -- their faith in human progress -- must always be the North Star that guides us on our journey.
So let us reach for the world that ought to be -- that spark of the divine that still stirs within each of our souls.
--President Obama
For if we lose that faith -- if we dismiss it as silly or naive; if we divorce it from the decisions that we make on issues of war and peace -- then we lose what is best about humanity. We lose our sense of possibility. We lose our moral compass.
Like generations have before us, we must reject that future. As Dr. King said at this occasion so many years ago, "I refuse to accept despair as the final response to the ambiguities of history. I refuse to accept the idea that the 'isness' of man's present nature makes him morally incapable of reaching up for the eternal 'oughtness' that forever confronts him."
So let us reach for the world that ought to be -- that spark of the divine that still stirs within each of our souls. Somewhere today, in the here and now, a soldier sees he's outgunned but stands firm to keep the peace. Somewhere today, in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on. Somewhere today, a mother facing punishing poverty still takes the time to teach her child, who believes that a cruel world still has a place for his dreams.
Let us live by their example. We can acknowledge that oppression will always be with us, and still strive for justice. We can admit the intractability of depravation, and still strive for dignity. We can understand that there will be war, and still strive for peace. We can do that -- for that is the story of human progress; that is the hope of all the world; and at this moment of challenge, that must be our work here on Earth.
Your majesties, your royal highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America and citizens of the world:
I receive this honor with deep gratitude and great humility. It is an award that speaks to our highest aspirations -- that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate. Our actions matter, and can bend history in the direction of justice.
And yet I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated. In part, this is because I am at the beginning, and not the end, of my labors on the world stage. Compared to some of the giants of history who have received this prize -- Schweitzer and King; Marshall and Mandela -- my accomplishments are slight. And then there are the men and women around the world who have been jailed and beaten in the pursuit of justice; those who toil in humanitarian organizations to relieve suffering; the unrecognized millions whose quiet acts of courage and compassion inspire even the most hardened of cynics. I cannot argue with those who find these men and women -- some known, some obscure to all but those they help -- to be far more deserving of this honor than I.
But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the commander in chief of a nation in the midst of two wars. One of these wars is winding down. The other is a conflict that America did not seek; one in which we are joined by forty-three other countries -- including Norway -- in an effort to defend ourselves and all nations from further attacks
Still, we are at war, and I am responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. Some will kill. Some will be killed. And so I come here with an acute sense of the cost of armed conflict -- filled with difficult questions about the relationship between war and peace, and our effort to replace one with the other.
These questions are not new. War, in one form or another, appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned; it was simply a fact, like drought or disease -- the manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences.
Over time, as codes of law sought to control violence within groups, so did philosophers, clerics and statesmen seek to regulate the destructive power of war. The concept of a "just war" emerged, suggesting that war is justified only when it meets certain preconditions: if it is waged as a last resort or in self-defense; if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence.
For most of history, this concept of just war was rarely observed. The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different God. Wars between armies gave way to wars between nations -- total wars in which the distinction between combatant and civilian became blurred. In the span of 30 years, such carnage would twice engulf this continent. And while it is hard to conceive of a cause more just than the defeat of the Third Reich and the Axis powers, World War II was a conflict in which the total number of civilians who died exceeded the number of soldiers who perished.
In the wake of such destruction, and with the advent of the nuclear age, it became clear to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another World War. And so, a quarter century after the United States Senate rejected the League of Nations -- an idea for which Woodrow Wilson received this prize -- America led the world in constructing an architecture to keep the peace: a Marshall Plan and a United Nations, mechanisms to govern the waging of war, treaties to protect human rights, prevent genocide and restrict the most dangerous weapons.
In many ways, these efforts succeeded. Yes, terrible wars have been fought, and atrocities committed. But there has been no Third World War. The Cold War ended with jubilant crowds dismantling a wall. Commerce has stitched much of the world together. Billions have been lifted from poverty. The ideals of liberty, self-determination, equality and the rule of law have haltingly advanced. We are the heirs of the fortitude and foresight of generations past, and it is a legacy for which my own country is rightfully proud.
A decade into a new century, this old architecture is buckling under the weight of new threats. The world may no longer shudder at the prospect of war between two nuclear superpowers, but proliferation may increase the risk of catastrophe. Terrorism has long been a tactic, but modern technology allows a few small men with outsized rage to murder innocents on a horrific scale.
Moreover, wars between nations have increasingly given way to wars within nations. The resurgence of ethnic or sectarian conflicts; the growth of secessionist movements, insurgencies, and failed states; have increasingly trapped civilians in unending chaos. In today's wars, many more civilians are killed than soldiers; the seeds of future conflict are sewn, economies are wrecked, civil societies torn asunder, refugees amassed and children scarred.
I do not bring with me today a definitive solution to the problems of war. What I do know is that meeting these challenges will require the same vision, hard work and persistence of those men and women who acted so boldly decades ago. And it will require us to think in new ways about the notions of just war and the imperatives of a just peace.
We must begin by acknowledging the hard truth that we will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations -- acting individually or in concert -- will find the use of force not only necessary but morally justified.
I make this statement mindful of what Martin Luther King said in this same ceremony years ago -- "Violence never brings permanent peace. It solves no social problem: it merely creates new and more complicated ones." As someone who stands here as a direct consequence of Dr. King's life's work, I am living testimony to the moral force of nonviolence. I know there is nothing weak -- nothing passive -- nothing naive -- in the creed and lives of Gandhi and King.
But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism -- it is a recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason.
To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism -- it is a recognition of history.
I raise this point because in many countries there is a deep ambivalence about military action today, no matter the cause. At times, this is joined by a reflexive suspicion of America, the world's sole military superpower.
Yet the world must remember that it was not simply international institutions -- not just treaties and declarations -- that brought stability to a post-World War II world. Whatever mistakes we have made, the plain fact is this: The United States of America has helped underwrite global security for more than six decades with the blood of our citizens and the strength of our arms. The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea, and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. We have borne this burden not because we seek to impose our will. We have done so out of enlightened self-interest -- because we seek a better future for our children and grandchildren, and we believe that their lives will be better if other peoples' children and grandchildren can live in freedom and prosperity.
So yes, the instruments of war do have a role to play in preserving the peace. And yet this truth must coexist with another -- that no matter how justified, war promises human tragedy. The soldier's courage and sacrifice is full of glory, expressing devotion to country, to cause and to comrades in arms. But war itself is never glorious, and we must never trumpet it as such.
So part of our challenge is reconciling these two seemingly irreconcilable truths -- that war is sometimes necessary, and war is at some level an expression of human feelings. Concretely, we must direct our effort to the task that President Kennedy called for long ago. "Let us focus," he said, "on a more practical, more attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature but on a gradual evolution in human institutions."
What might this evolution look like? What might these practical steps be?
To begin with, I believe that all nations -- strong and weak alike -- must adhere to standards that govern the use of force. I -- like any head of state -- reserve the right to act unilaterally if necessary to defend my nation. Nevertheless, I am convinced that adhering to standards strengthens those who do, and isolates -- and weakens -- those who don't.
The world rallied around America after the 9/11 attacks, and continues to support our efforts in Afghanistan, because of the horror of those senseless attacks and the recognized principle of self-defense. Likewise, the world recognized the need to confront Saddam Hussein when he invaded Kuwait -- a consensus that sent a clear message to all about the cost of aggression.
Furthermore, America cannot insist that others follow the rules of the road if we refuse to follow them ourselves. For when we don't, our action can appear arbitrary, and undercut the legitimacy of future intervention -- no matter how justified.
This becomes particularly important when the purpose of military action extends beyond self-defense or the defense of one nation against an aggressor. More and more, we all confront difficult questions about how to prevent the slaughter of civilians by their own government, or to stop a civil war whose violence and suffering can engulf an entire region.
I believe that force can be justified on humanitarian grounds, as it was in the Balkans, or in other places that have been scarred by war. Inaction tears at our conscience and can lead to more costly intervention later. That is why all responsible nations must embrace the role that militaries with a clear mandate can play to keep the peace.
America's commitment to global security will never waiver. But in a world in which threats are more diffuse, and missions more complex, America cannot act alone. This is true in Afghanistan. This is true in failed states like Somalia, where terrorism and piracy is joined by famine and human suffering. And sadly, it will continue to be true in unstable regions for years to come.
The leaders and soldiers of NATO countries -- and other friends and allies -- demonstrate this truth through the capacity and courage they have shown in Afghanistan. But in many countries, there is a disconnect between the efforts of those who serve and the ambivalence of the broader public. I understand why war is not popular. But I also know this: The belief that peace is desirable is rarely enough to achieve it. Peace requires responsibility. Peace entails sacrifice. That is why NATO continues to be indispensable. That is why we must strengthen U.N. and regional peacekeeping, and not leave the task to a few countries. That is why we honor those who return home from peacekeeping and training abroad to Oslo and Rome; to Ottawa and Sydney; to Dhaka and Kigali -- we honor them not as makers of war, but as wagers of peace.
Let me make one final point about the use of force. Even as we make difficult decisions about going to war, we must also think clearly about how we fight it. The Nobel Committee recognized this truth in awarding its first prize for peace to Henry Dunant -- the founder of the Red Cross, and a driving force behind the Geneva Conventions.
Where force is necessary, we have a moral and strategic interest in binding ourselves to certain rules of conduct. And even as we confront a vicious adversary that abides by no rules, I believe that the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different from those whom we fight. That is a source of our strength. That is why I prohibited torture. That is why I ordered the prison at Guantanamo Bay closed. And that is why I have reaffirmed America's commitment to abide by the Geneva Conventions. We lose ourselves when we compromise the very ideals that we fight to defend. And we honor those ideals by upholding them not just when it is easy, but when it is hard.
I have spoken to the questions that must weigh on our minds and our hearts as we choose to wage war. But let me turn now to our effort to avoid such tragic choices, and speak of three ways that we can build a just and lasting peace.
First, in dealing with those nations that break rules and laws, I believe that we must develop alternatives to violence that are tough enough to change behavior -- for if we want a lasting peace, then the words of the international community must mean something. Those regimes that break the rules must be held accountable. Sanctions must exact a real price. Intransigence must be met with increased pressure -- and such pressure exists only when the world stands together as one.
One urgent example is the effort to prevent the spread of nuclear weapons, and to seek a world without them. In the middle of the last century, nations agreed to be bound by a treaty whose bargain is clear: All will have access to peaceful nuclear power; those without nuclear weapons will forsake them; and those with nuclear weapons will work toward disarmament. I am committed to upholding this treaty. It is a centerpiece of my foreign policy. And I am working with President [Dmitry] Medvedev to reduce America and Russia's nuclear stockpiles.
But it is also incumbent upon all of us to insist that nations like Iran and North Korea do not game the system. Those who claim to respect international law cannot avert their eyes when those laws are flouted. Those who care for their own security cannot ignore the danger of an arms race in the Middle East or East Asia. Those who seek peace cannot stand idly by as nations arm themselves for nuclear war.
The same principle applies to those who violate international law by brutalizing their own people. When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma -- there must be consequences. And the closer we stand together, the less likely we will be faced with the choice between armed intervention and complicity in oppression.
This brings me to a second point -- the nature of the peace that we seek. For peace is not merely the absence of visible conflict. Only a just peace based upon the inherent rights and dignity of every individual can truly be lasting.
It was this insight that drove drafters of the Universal Declaration of Human Rights after the Second World War. In the wake of devastation, they recognized that if human rights are not protected, peace is a hollow promise.
And yet all too often, these words are ignored. In some countries, the failure to uphold human rights is excused by the false suggestion that these are Western principles, foreign to local cultures or stages of a nation's development. And within America, there has long been a tension between those who describe themselves as realists or idealists -- a tension that suggests a stark choice between the narrow pursuit of interests or an endless campaign to impose our values.
I reject this choice. I believe that peace is unstable where citizens are denied the right to speak freely or worship as they please; choose their own leaders or assemble without fear. Pent-up grievances fester, and the suppression of tribal and religious identity can lead to violence. We also know that the opposite is true. Only when Europe became free did it finally find peace. America has never fought a war against a democracy, and our closest friends are governments that protect the rights of their citizens. No matter how callously defined, neither America's interests -- nor the world's -- are served by the denial of human aspirations.
So even as we respect the unique culture and traditions of different countries, America will always be a voice for those aspirations that are universal. We will bear witness to the quiet dignity of reformers like Aung San Suu Kyi; to the bravery of Zimbabweans who cast their ballots in the face of beatings; to the hundreds of thousands who have marched silently through the streets of Iran. It is telling that the leaders of these governments fear the aspirations of their own people more than the power of any other nation. And it is the responsibility of all free people and free nations to make clear to these movements that hope and history are on their side
Let me also say this: The promotion of human rights cannot be about exhortation alone. At times, it must be coupled with painstaking diplomacy. I know that engagement with repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation. But I also know that sanctions without outreach -- and condemnation without discussion -- can carry forward a crippling status quo. No repressive regime can move down a new path unless it has the choice of an open door.
In light of the Cultural Revolution's horrors, Nixon's meeting with Mao appeared inexcusable -- and yet it surely helped set China on a path where millions of its citizens have been lifted from poverty, and connected to open societies. Pope John Paul's engagement with Poland created space not just for the Catholic Church, but for labor leaders like Lech Walesa. Ronald Reagan's efforts on arms control and embrace of perestroika not only improved relations with the Soviet Union, but empowered dissidents throughout Eastern Europe. There is no simple formula here. But we must try as best we can to balance isolation and engagement; pressure and incentives, so that human rights and dignity are advanced over time.
Third, a just peace includes not only civil and political rights -- it must encompass economic security and opportunity. For true peace is not just freedom from fear, but freedom from want.
It is undoubtedly true that development rarely takes root without security; it is also true that security does not exist where human beings do not have access to enough food, or clean water, or the medicine they need to survive. It does not exist where children cannot aspire to a decent education or a job that supports a family. The absence of hope can rot a society from within.
And that is why helping farmers feed their own people -- or nations educate their children and care for the sick -- is not mere charity. It is also why the world must come together to confront climate change. There is little scientific dispute that if we do nothing, we will face more drought, famine and mass displacement that will fuel more conflict for decades. For this reason, it is not merely scientists and activists who call for swift and forceful action -- it is military leaders in my country and others who understand that our common security hangs in the balance.
Agreements among nations. Strong institutions. Support for human rights. Investments in development. All of these are vital ingredients in bringing about the evolution that President Kennedy spoke about. And yet, I do not believe that we will have the will, or the staying power, to complete this work without something more -- and that is the continued expansion of our moral imagination; an insistence that there is something irreducible that we all share.
As the world grows smaller, you might think it would be easier for human beings to recognize how similar we are; to understand that we all basically want the same things; that we all hope for the chance to live out our lives with some measure of happiness and fulfillment for ourselves and our families.
And yet, given the dizzying pace of globalization, and the cultural leveling of modernity, it should come as no surprise that people fear the loss of what they cherish about their particular identities -- their race, their tribe, and perhaps most powerfully their religion. In some places, this fear has led to conflict. At times, it even feels like we are moving backwards. We see it in Middle East, as the conflict between Arabs and Jews seems to harden. We see it in nations that are torn asunder by tribal lines.
Most dangerously, we see it in the way that religion is used to justify the murder of innocents by those who have distorted and defiled the great religion of Islam, and who attacked my country from Afghanistan. These extremists are not the first to kill in the name of God; the cruelties of the Crusades are amply recorded. But they remind us that no Holy War can ever be a just war. For if you truly believe that you are carrying out divine will, then there is no need for restraint -- no need to spare the pregnant mother, or the medic, or even a person of one's own faith. Such a warped view of religion is not just incompatible with the concept of peace, but the purpose of faith -- for the one rule that lies at the heart of every major religion is that we do unto others as we would have them do unto us.
Adhering to this law of love has always been the core struggle of human nature. We are fallible. We make mistakes, and fall victim to the temptations of pride, and power, and sometimes http://michaeljackson.forumup.it/images/smiles/motocanaglia_fuoco.gif. Even those of us with the best intentions will at times fail to right the wrongs before us.
But we do not have to think that human nature is perfect for us to still believe that the human condition can be perfected. We do not have to live in an idealized world to still reach for those ideals that will make it a better place. The nonviolence practiced by men like Gandhi and King may not have been practical or possible in every circumstance, but the love that they preached -- their faith in human progress -- must always be the North Star that guides us on our journey.
So let us reach for the world that ought to be -- that spark of the divine that still stirs within each of our souls.
--President Obama
For if we lose that faith -- if we dismiss it as silly or naive; if we divorce it from the decisions that we make on issues of war and peace -- then we lose what is best about humanity. We lose our sense of possibility. We lose our moral compass.
Like generations have before us, we must reject that future. As Dr. King said at this occasion so many years ago, "I refuse to accept despair as the final response to the ambiguities of history. I refuse to accept the idea that the 'isness' of man's present nature makes him morally incapable of reaching up for the eternal 'oughtness' that forever confronts him."
So let us reach for the world that ought to be -- that spark of the divine that still stirs within each of our souls. Somewhere today, in the here and now, a soldier sees he's outgunned but stands firm to keep the peace. Somewhere today, in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on. Somewhere today, a mother facing punishing poverty still takes the time to teach her child, who believes that a cruel world still has a place for his dreams.
Let us live by their example. We can acknowledge that oppression will always be with us, and still strive for justice. We can admit the intractability of depravation, and still strive for dignity. We can understand that there will be war, and still strive for peace. We can do that -- for that is the story of human progress; that is the hope of all the world; and at this moment of challenge, that must be our work here on Earth.

szwaby82- Messaggi : 4159
Data d'iscrizione : 10.10.11
 Argomenti simili
Argomenti simili» Pensieri di Pace
» GIORNATA DELLA PACE
» Albert Einstein:messaggio di pace
» GIORNATA MONDIALE PER LA PACE....SOLO L ITALIA NON FESTEGGIA
» Obama ricorda Martin Luther King
» GIORNATA DELLA PACE
» Albert Einstein:messaggio di pace
» GIORNATA MONDIALE PER LA PACE....SOLO L ITALIA NON FESTEGGIA
» Obama ricorda Martin Luther King
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.